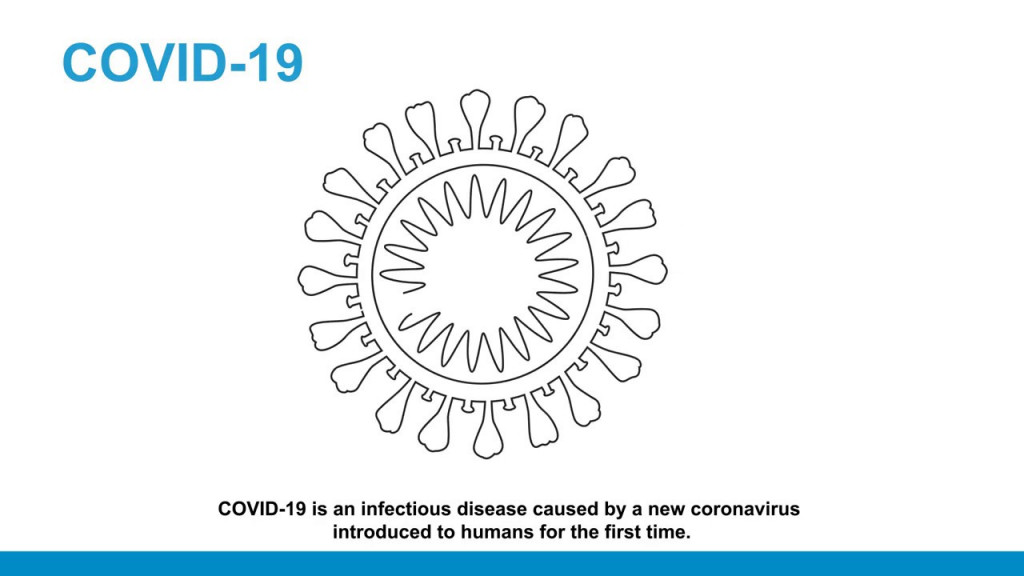L’anoressia nervosa è un disturbo mentale incluso nella più ampia classificazione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione definiti nel manuale diagnostico DSM (APA, 2013).
È caratterizzata da una “restrizione dell’introito energetico rispetto al fabbisogno tale da condurre a un peso corporeo significativamente basso in rapporto all’età̀, al sesso, alla traiettoria evolutiva e alla salute fisica”.
È inoltre caratterizzata dall’intensa paura di aumentare di peso, dall’alterazione della percezione del peso e delle proprie forme corporee. Infine si nota una grande influenza del peso e delle forme corporee sulla percezione del proprio valore personale e senso di autostima.
In alcuni casi si presenta in comorbidità con altri disturbi come disturbi d’ansia, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo da stress post traumatico e disturbo di personalità (Jagielska, G., & Kacperska, I., 2017).
È un disturbo che procura elevati livelli di sofferenza personale e di disagio interpersonale e che ha un impatto in varie aree del funzionamento personale, scolastico, lavorativo e sociale e che può causare diverse complicazioni mediche.
L’anoressia nervosa è maggiormente diffusa nella popolazione femminile anche se negli ultimi anni si è osservato un aumento dei casi di anoressia nervosa maschile.
L’incidenza di questo disturbo è di 8-9 nuovi casi per 100mila persone in un anno tra le donne, mentre è compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi casi maschili (salute.gov.it).
L’età in cui avviene tipicamente l’esordio è compresa tra i 15 e i 25 anni anche se recentemente si è osservato un abbassamento medio dell’età di esordio (https://www.epicentro.iss.it/anoressia).
Dalla letteratura sembrano essere più a rischio le persone di sesso femminile specialmente nella fase dell’adolescenza e della prima giovinezza. Sembra essere un fattore di rischio anche aver avuto una condizione di sovrappeso o obesità nell’infanzia o nell’adolescenza e avere fatto diete con l’obiettivo di perdere peso e l’aver subito episodi di bullismo (Cena H. et al., 2017).
Sembrano avere un ruolo anche specifiche caratteristiche psicologiche come la bassa autostima nucleare e il perfezionismo patologico, tratti ossessivi di personalità, il rifiuto del corpo adulto e della sessualità; difficoltà relazionali con gli adulti di riferimento (Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R., 2003).
In questo senso il clima familiare potrebbe svolgere un ruolo in particolare se presente un elevato livello di critiche genitoriali, elevati standard di prestazione o una particolare attenzione per la cura dell’aspetto fisico e dell’alimentazione.
Sulle diverse caratteristiche individuali e familiari hanno un impatto anche i valori socioculturali tipici del mondo occidentale, come la competitività, la richiesta di prestazioni straordinarie e l’esaltazione della magrezza. Attualmente sembra realizzarsi un incremento degli esordi di anoressia nervosa durante il periodo di lockdown a causa della pandemia COVID-19 (Ünver, H. et al., 2020).
Riconoscere l’anoressia nervosa è sicuramente il primo fondamentale passo per affrontare il problema.
Spesso, vista l’età d’esordio precoce e le caratteristiche del disturbo percepite come positive o scelte personali (controllo sul cibo, rinforzi e senso di efficacia legato alla competenza percepita per la perdita di peso) sono le persone vicine a chi ne soffre a rendersi per prime conto che c’è un problema alimentare.
I segnali che possono far sospettare la presenza di anoressia nervosa sono in primo luogo la perdita di peso e, nel caso delle ragazze la perdita del ciclo mestruale.
Il calo di peso può essere più o meno repentino e si presenta associato a una limitazione dell’alimentazione (evitamento dei carboidrati, cibi grassi o elaborati) e spesso all’evitamento delle situazioni sociali associate al cibo (pranzi in famiglia, cene fuori, feste etc..).
Spesso si può notare un aumento dell’attività fisica che in alcuni casi può anche configurarsi come un quadro di attività fisica in eccesso. Da un punto di vista emotivo e cognitivo si possono notare un aumento di irritabilità, umore basso, ossessività e perdita di concentrazione. Infine da un punto di vista comportamentale sono spesso rilevabili comportamenti come l’isolamento sociale, rituali durante i pasti (spezzettare il cibo, nasconderlo, renderlo poco gradevole al gusto, eccessivo consumo di the, caffè, acqua e tisane).
L’anoressia nervosa per le sue caratteristiche cliniche che determinano una compromissione sia sul piano somatico che psichico necessita di trattamenti specialistici multidisciplinari e integrati (Ballardini, D., & Schumann, R., 2011).
Il trattamento psicoterapico d’elezione suggerito dalle linee guida internazionali (APA, 2013; NICE 2017) è quello cognitivo comportamentale a cui è fondamentale affiancare una riabilitazione pscionutrizionale da parte di un medico specialista in scienza dell’alimentazione al fine di assicurare la gestione di eventuali complicanze mediche e permettere un sano recupero del peso (Ministero della Salute, 2017).
Da un punto di vista psicoterapico la terapia cognitivo comportamentale permette, non solo la comprensione e la cura degli aspetti sottostanti il disturbo (come ad esempio la bassa autostima, il perfezionismo clinico, presenza di traumi pregressi) ma anche il lavoro sul sintomo attraverso strategie specifiche per il trattamento del disturbo alimentare (come strategie per gestire l’ansia associata alle necessarie modifiche alimentari, promozione della motivazione al cambiamento, promozione di strategie di comunicazione altre rispetto al sintomo).
Il trattamento multidisciplinare integrato inoltre è l’impostazione chiave nel trattamento a tutti i livelli di cura che nell’area dei disturbi alimentari possono essere: ambulatoriale, day-hospital, semi-residenziale, residenziale riabilitativo e ospedaliero.
In conclusione ci preme ricordare che la guarigione dall’anoressia nervosa è possibile, è un percorso complesso in cui è necessaria non solo la gestione dell’anoressia stessa ma anche dei disturbi in comorbidità se presenti, come per esempio vissuti traumatici antecedenti l’esordi del disturbo alimentare che richiedono l’integrazione di interventi di traumaterapia all’interno del percorso specialistico multiprofessionale per il disturbo della nutrizione e dell’alimentazione. Le terapie devono essere caratterizzate da una presa in carico globale della persona che soffre del disturbo e della sua famiglia e fornire una risposta terapeutica ad hoc e personalizzata.
Dott.ssa Chiara Mazzoni Psicologa-Psicoterapeuta
Dott.ssa Valentina Fasoli Psicologa-Psicoterapeuta
Dott.ssa Romana Schumann Psicologa-Psicoterapeuta Centro Gruber, Via Santo Stefano 10, Bologna
Soffri di Anoressia e hai bisogno di una consulenza psicologica ?
Contatta ora uno Psicoterapeuta nella tua zona
In alternativa inviaci la tua richiesta tramite il form